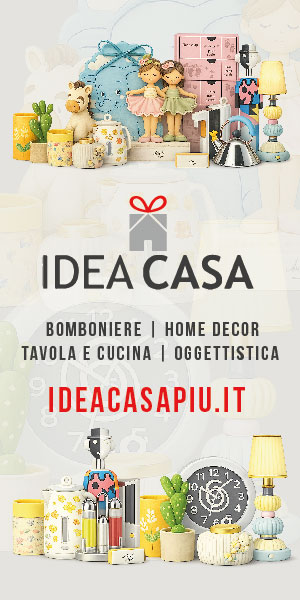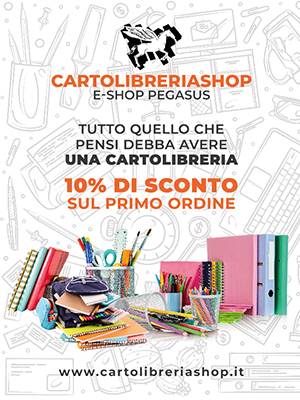E’ stato pubblicato il primo monitoraggio del Piano Aria e Clima del Comune di Milano, relativo allo stato di avanzamento delle azioni e dei risultati conseguiti nelle annualità 2022-2023.
Il Piano Aria e Clima (PAC), approvato nel 2022, ha l’obiettivo di tutelare la qualità della vita e il benessere di cittadini e cittadine. Le sfide del Piano sono quelle di migliorare la qualità dell’aria, e quindi rispettare i limiti dell’Unione Europea avvicinandosi a quelli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di CO2 (-45% rispetto al 2005 con le azioni locali) e contenere l’aumento della temperatura locale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso azioni di adattamento.
Per portare avanti queste sfide, il Piano ha individuato cinque ambiti di intervento (Milano sana e inclusiva, Milano connessa e altamente accessibile, Milano ad energia positiva, Milano più fresca, Milano consapevole) ai quali sono associate azioni specifiche che, con una visione di lungo periodo della città al 2050, definiscono obiettivi intermedi da raggiungere nel 2030.
In via generale, per quanto riguarda la qualità dell’aria e la decarbonizzazione, gli esiti dell’efficacia complessiva del PAC mostrano un andamento in linea con le sfide e i relativi obiettivi di breve-medio termine definiti all’epoca dell’approvazione. Un risultato dovuto sia a un generale miglioramento dello scenario di riferimento, sia al fatto che il PAC ha attivato un processo di maggiore attenzione, consapevolezza e allineamento verso obiettivi e pratiche comuni, generando quindi effetti positivi e sinergici. Per quanto riguarda l’adattamento, considerando l’incremento delle temperature superficiali, risulta importante accelerare le azioni programmate introducendo misure più incisive.
Qualità dell’aria
Per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell’aria della città, il valore massimo delle concentrazioni medie annue di NO2 (biossido d’azoto) è risultato nel 2023 pari a 44 microgrammi per metro cubo, un dato in diminuzione dal 2017 (64 microgrammi per metro cubo), coerentemente con il trend atteso.
Nel 2024 per la prima volta, inoltre, tutte le stazioni di Milano hanno rispettato il valore limite della Direttiva Europea del 2008, anticipando la sfida PAC di medio periodo, che ne prevedeva il rispetto al 2025. Al contrario, nel 2017 tutte le stazioni della città oltrepassavano il limite della Direttiva.
Inoltre, Area B ha giocato un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di NO2 da traffico stradale e, conseguentemente, nella riduzione delle concentrazioni di NO2.
Un’analisi ha confrontato le concentrazioni di ossidi di azoto dentro e fuori Milano: dal 2008 al 2018, la diminuzione delle concentrazioni era simile in entrambe le aree. Dopo l’introduzione di Area B (dal 2018 al 2024), il tasso di diminuzione degli ossidi di azoto è stato invece più rapido all’interno di Milano rispetto all’esterno, confermando l’efficacia della misura.
Per quanto riguarda le polveri sottili, nel 2023 il valore massimo delle concentrazioni di PM10 è risultato pari a 32 microgrammi per metro cubo, contro i 37 microgrammi per metro cubo rilevati nel 2021 e i 40 microgrammi per metro cubo del 2017. Un dato positivo in riduzione – che ha beneficiato anche di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione di inquinanti – che evidenzia, però, un trend non sempre stabile e costante, insufficiente per affermare con certezza il rispetto dei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti entro il 2025.
Analogo il dato positivo relativo ai valori massimi delle concentrazioni di PM2.5, per le quali nel 2023 si è registrato un valore pari a 21 microgrammi per metro cubo a fronte dei 24 del 2021 e dei 29 microgrammi per metro cubo del 2017.
Tenuto conto delle importanti riduzioni dei valori limite introdotti dalla nuova Direttiva UE non ancora recepita in Italia, e dei valori obiettivo dell’OMS rivisti al ribasso, i miglioramenti della qualità dell’aria conseguiti non delineano un trend sulla base del quale si possa ipotizzare il raggiungimento dei nuovi standard nel breve periodo. Dato il contesto e la posizione geografica di Milano – che rende ancor più urgente l’adozione di politiche integrate sovracomunali anche a livello regionale – è importante rendere ancora più incisive le azioni programmate, oltre che proseguire le buone pratiche locali intraprese, come Area B. Una misura che si è dimostrata efficace sulla riduzione delle concentrazioni di NO2, dovute per il 55% a emissioni interne alla città, ma che non può agire sul restante 45%. In parallelo occorre prevedere azioni complementari per ridurre in modo costante i valori di PM10 e PM2.5. Le stime indicano che il 75% del particolato atmosferico a Milano proviene da fonti emissive esterne alla città: anche in questo caso servono quindi soprattutto politiche integrate a livello sovracomunale.
Tra le azioni del PAC che contribuiscono in modo significativo al miglioramento della qualità dell’aria, incentivando l’uso della mobilità dolce e riducendo quindi la produzione di sostanze composti inquinanti, vanno considerate l’estensione delle zone 30 km/h, delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali nonché la riqualificazione dei parterre alberati, solitamente utilizzati abusivamente per la sosta irregolare, l’aumento delle piste ciclabili e degli stalli per le biciclette.
Mitigazione
Per quanto riguarda la mitigazione delle emissioni di CO2, il monitoraggio evidenzia nel biennio 2022-2023 una riduzione dell’8,7% (-32,9% rispetto al 2005), dimostrando l’efficacia – insieme ai benefici attribuibili a fattori esterni, come le temperature invernali più miti – delle azioni avviate con il Piano tra cui la progressiva eliminazione del gasolio per il riscaldamento, la promozione dell’uso della geotermia e del fotovoltaico.
Fondamentale sarà nei prossimi anni proseguire incisivamente con queste azioni in un quadro di pianificazione energetica a livello territoriale volto a razionalizzare l’uso delle risorse e infrastrutture energetiche e a implementare le energie rinnovabili locali.
Considerando la tendenza rilevata nel monitoraggio si ritiene possibile raggiungere l’obiettivo di medio termine del PAC di riduzione emissioni di CO2 pari al 45% rispetto al 2005.
Adattamento
L’andamento delle temperature superficiali estive ha mostrato, dal 2017 al 2023, un costante aumento. Obiettivo a lungo termine al 2050 del Piano Aria e Clima è di contribuire a contenere l’aumento locale delle temperature dell’aria entro i 2 C° tramite azioni di raffrescamento e di riduzione delle isole di calore attraverso l’aumento del patrimonio del verde e anche tramite le depavimentazioni.
Ipotizzando di mantenere l’attuale morfologia urbana, è stato stimato l’aumento di circa 2,5 C° al 2050, superando l’obiettivo di 0,5 C°. Nonostante le aree verdi pubbliche siano già aumentate di 10,5 ettari dal 2017 al 2023, le simulazioni effettuate per garantire il contenimento delle temperature locali al 2050, ipotizzano la necessità di aumentare la copertura arborea del 41% e di depavimentare circa 100 ettari di superficie attualmente grigia.
Per rispettare quindi la sfida di Piano sarà necessario, entro il 2050, aumentare in modo consistente il verde urbano, la copertura arborea e le depavimentazioni, considerando anche altre soluzioni complementari, come l’integrazione del verde negli edifici, l’uso di superfici riflettenti, l’ombreggiamento degli spazi pubblici, l’aumento dell’accessibilità a luoghi freschi.
“I risultati del primo monitoraggio del Piano Aria e Clima ci dimostrano che la strada intrapresa, seppur ambiziosa, è quella giusta – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Ce lo dicono i valori in discesa delle emissioni annue di C02, legate ai consumi energetici, così come quelli delle concentrazioni medie annue di biossido di azoto e di Pm10 e Pm2.5; ce lo dicono i risultati di Area B confermando una riduzione delle concentrazioni di ossidi di azoto nel perimetro della città, superiore a quello che avviene all’esterno. La nuova direttiva europea per la qualità dell’aria inasprisce con limiti più stringenti i valori degli inquinanti atmosferici e questo rende certamente la nostra strada ancora più in salita e ci richiederà sforzi sempre maggiori: ma anche per questo motivo – come sosteniamo da sempre – Milano non può farcela da sola. L’inquinamento dell’aria non ha confini amministrativi, l’impatto sulle concentrazioni in città delle emissioni prodotte al di fuori del perimetro è rilevante (75% sul Pm10, 79% sul Pm2,5 e 45% su NO2), per questo le politiche per la tutela della qualità dell’aria devono essere sempre più incisive, integrate e condivise a livello sovracomunale e regionale per essere efficaci. Sul fronte dell’adattamento ai cambiamenti climatici, infine, diventano ancor più necessarie, in contesti urbani, azioni e soluzioni nuove, alternative e complementari all’aumento del solo verde in città: allo stato attuale, per contenere l’aumento della temperatura al 2050 entro +2°C (rispetto al 2017) dovremmo aumentare la copertura arborea del 41%. Un obiettivo che sappiamo essere difficilmente raggiungibile e che proprio per questo richiederà maggiori investimenti di risorse pubbliche e una programmazione stringente di interventi sullo spazio pubblico”.
Scopri di più da GazzettadiMilano.it
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.